Siamo pronti per progettare in modo davvero sostenibile?
Condividi
Green, a tutti i costi!
Sembra questo l’imperativo a cui il mondo ci sta esortando negli ultimi anni, e nell’epoca della crisi climatica la sostenibilità è una scelta da cui nessuno può esimersi, nemmeno l’edilizia e l’architettura.
Ma si sa che “dal dire al fare” il passo non è così semplice e la stessa definizione di architettura green assume sfaccettature multiple e in continua evoluzione.
Cosa significa fare architettura green?
Usare risorse rinnovabili, avvalersi solo di materiali ecologici, sostenibili, riciclati e riciclabili, studiare sistemi innovativi per ottimizzare le risorse energetiche e rendere gli edifici meno energivori: tutti questi fattori sono fondamentali per rendere l’edificio green, ma l’architettura di oggi sta diventando davvero più sostenibile e come si progetta in chiave green?
Lo abbiamo chiesto all’architetto Enrico Molteni, giurato italiano del BigMat International Architecture Award 2023 (premio biennale di architettura giunto alla sesta edizione) che racconta come il nostro Paese non sia ancora del tutto pronto e come il tema della sostenibilità rischia di trasformarsi in un’operazione di “green washing” se non si inizia a progettare in modo consapevole ed ecologico.
Come poter metter in atto questo cambiamento è la grande sfida che devono affrontare gli architetti, i quali devono lavorare in equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e normative da rispettare, prendendo ad esempio l’edilizia pubblica che, per l’architetto Molteni, sta rispondendo in modo “costruttivo” agli stringenti criteri green.
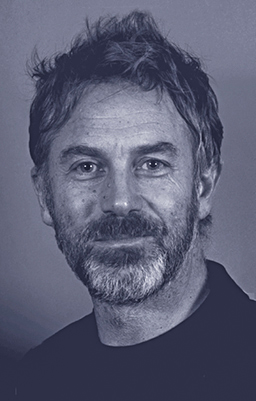
L’architettura italiana si dimostra sensibile al tema green?
A mio parere si possono considerare due piani distinti: quello dell’industria delle costruzioni e degli interventi edilizi e quello dell’architettura e dei bandi dei concorsi. Da un lato ritengo che la sostenibilità sia utilizzata solo in modo commerciale, e quindi superficiale o direi addirittura “falsa”: mi riferisco per esempio agli edifici realizzati recentemente a Milano che, seppur conformi ad alcuni protocolli e alle normative, non hanno nulla di sostenibile in termini ecologici. In questa stessa ottica ritengo anche che la maggior parte degli interventi eseguiti grazie al Superbonus 110% possa essere considerata, in fondo, ben poco sostenibile. Al contrario è invece presente un profondo cambiamento relativo alle opere pubbliche, in particolare quelle messe a concorso di progettazione, che da alcuni anni sono molto esigenti su tutti gli aspetti di sostenibilità. Questo cambiamento sta producendo un conseguente rinnovamento nelle proposte di progetto. Da parte degli architetti più impegnati la questione green è stata affrontata seriamente e non superficialmente, ovvero non solo mettendo delle fioriere sulle facciate o utilizzando il legno anche quando non è necessario.
A cosa deve prestare maggiormente attenzione un architetto che vuole progettare edifici green?
I principi generali sono gli stessi di sempre: efficienza, rispetto dei luoghi, ovvero clima, compattezza del volume e profondità dei corpi di fabbrica, rapporto equilibrato tra facciate aperte e chiuse e controllo della luce naturale. Per quanto riguarda i materiali e gli impianti, invece, le normative e l’economia hanno un ruolo tale che le scelte sono spesso “obbligate”. Inoltre, va considerato che, purtroppo, la visione attuale vede nella tecnologia una specie di “salvezza” per il futuro, portando a un uso spesso sconsiderato di materiali “innovativi” e impianti di ogni genere. Al contrario, si dovrebbe tendere a edifici (quasi) “privi” di impianti e a una riduzione drastica delle componenti costruttive, che invece abbondano sempre di più, in modo spesso spropositato. Di fatto la sostenibilità economica dovrebbe assumere un ruolo pari a quello della sostenibilità ecologica, mentre al momento si opera secondo il principio del “costi quel che costi, ma deve essere innovativo/green”, con fini puramente commerciali.
Un aspetto trascurato, ma molto importante, è poi quello relativo alla ricerca di soluzioni architettoniche sempre più generiche, neutre, flessibili, ovvero architetture che possano essere disponibili nel lungo tempo, capaci di dare risposta alle esigenze di uso in continua e rapida evoluzione. Il contrario di quanto invece sta avvenendo e che avverrà ancor di più con l’uso dell’Intelligenza Artificiale in fase di progettazione.
C’è qualche opera in Italia che considera un modello di architettura green da seguire?
Purtroppo, l’architettura in Italia è un fatto molto sporadico, la maggior parte è inoltre di iniziativa privata, divisa tra grandi edifici e piccolissime opere.
Al momento non credo esistano modelli, al di là del Bosco Verticale di Milano, che ha espresso con perfetto tempismo il tema della sostenibilità e del green, ma solo in superficie, una sorta di manifesto pubblicitario pienamente riuscito.
Il comparto della produzione di materiali edili come può supportare architetti e progettisti nel perseguire un’edilizia sempre più green?
Per quanto concerne la produzione di materiali e sistemi costruttivi, credo che si tratterà di una ricerca principalmente sostenuta dal mercato di cui l’architettura è una parte irrisoria. In genere le collaborazioni tra produttore di materiali e progettisti sono molto proficue, sia in termini di risultati della ricerca sia in termini di diffusione mediatica. Faccio l’esempio di un piccolo produttore di mattoni danesi che è diventato leader nel settore e ha poi influenzato molti altri produttori, partendo proprio dalla collaborazione con l’architetto Peter Zumthor per il progetto del Kolumba Museum di Colonia.
In qualità di giurato del BMIAA ’23, quanto inciderà il requisito della sostenibilità nella valutazione dei progetti in gara?
Credo che inciderà come uno dei criteri di valutazione, ma mai come parametro valido di per sé. Un buon edificio green può essere anche una pessima opera di architettura e viceversa, si tratterà quindi di capire la qualità dell’insieme del progetto e non solo i singoli aspetti dell’opera in concorso.
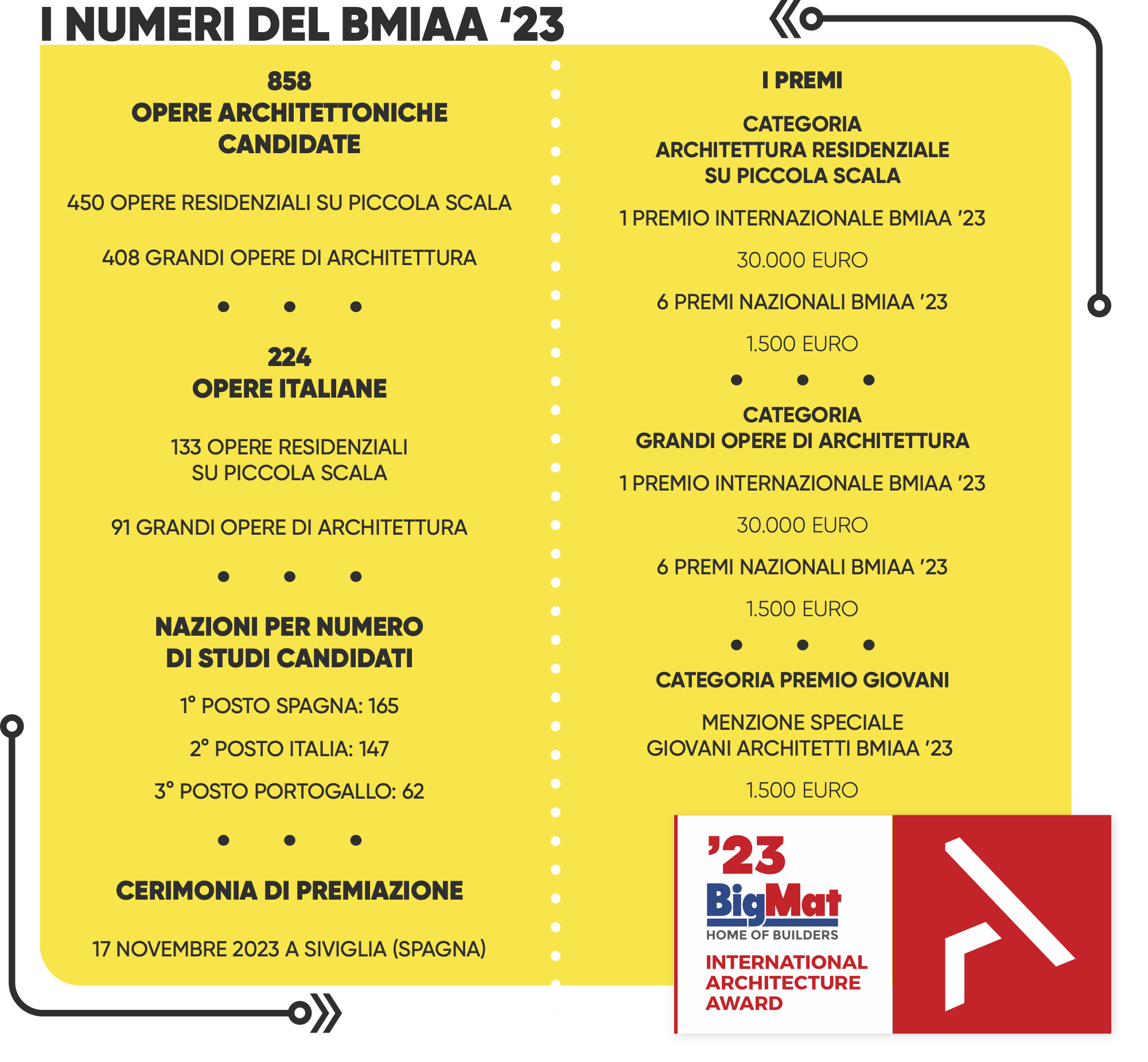
Condividi